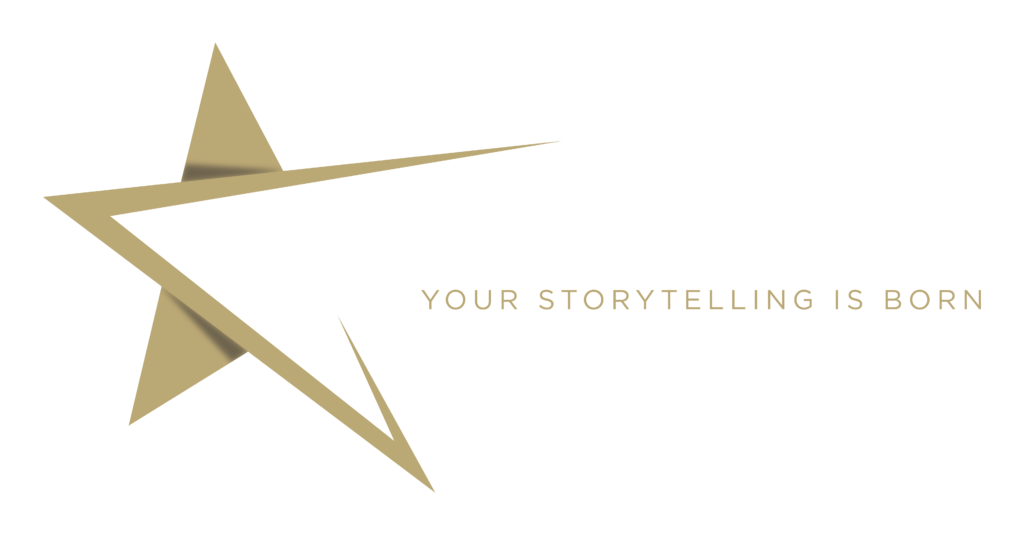Che cos’è la scrittura e perché si scrive? La scrittura ci deve insegnare qualcosa? Orwell e Primo Levi, che hanno combattuto il totalitarismo, esprimono vocazioni totalitarie quando parlano della scrittura. Per Calvino invece la scrittura non deve avere vocazioni pedagogiche (che sono intrinsecamente totalitarie). E questo è anche quello che ci dice Giuseppe Ungaretti, per il quale il senso stesso delle sue opere è un mistero, confortato addirittura da Sigmund Freud che ci parla dell’inconscio. Ma sarebbe anche bene non prendersi troppo sul serio, come ci invita a fare Giovanni Pascoli ironizzando sulla funzione dell’artista.
Alla fine, dietro lo scrittore – e l’artista in genere – che si prende troppo sul serio, cova il pedagogo che vorrebbe assegnare all’Arte un fine, come dice anche Baudelaire. Ma quando l’arte non insegna nulla è libera e divina. Anche per questore scuole e le tecniche di scrittura sono idiozie, ma di questo parleremo un’altra volta.
Scrittura e totalitarismo
George Orwell richiama alla memoria colui che ha denunciato le tendenze totalitarie della nostra epoca, il suo è stato un appello allo spirito di libertà, culturale, intellettuale, politica. Orwell è anche quel giornalista che nella difficilissima situazione della guerra civile spagnola cercava di raccontare la politica di terrore e di sterminio intrapresa da Stalin contro anarchici e trotskisti, democratici e indipendenti. Dall’autore di “1984” e de “La fattoria degli animali”, ci aspetteremmo dunque adesione e coerenza a questo canone etico.
Eppure, chiamato da una rivista a spiegare le sue motivazioni di scrittore, Orwell esprime subito un punto di vista “generale”. Le sue personali motivazioni a scrivere sono esposte come le motivazioni di tutti gli scrittori, anzi dello “scrittore”. E’ vero che afferma che “queste diverse motivazioni possono entrare in conflitto reciproco e possono variare da persona a persona” (George Orwell, Perché scrivo, 1946, in: Romanzi e saggi, I Meridiani, Mondadori, 2000) e tuttavia le indica con grande precisione.

Secondo Orwell si scrive solo ed esclusivamente per quattro motivi: egoismo, entusiasmo estetico, impulso storico e intento politico. Se noi consideriamo i romanzi di Orwell come tali, vale a dire come racconti, come storie che, come tutti i romanzi, sono interpretabili da diversi punti di vista, possiamo concludere che anche i libri di Orwell non facciano eccezione. Li trattiamo, cioè, come racconti, come storie. Quello che avviene tra un lettore e un racconto è un “dialogo” (Giulio Ferroni). L’approccio non può che essere personale, per questo esistono punti di vista anche molto diversi in merito a un romanzo, a un film, a un’opera d’arte. Perché l’arte non ha di per sé una funzione pedagogica. Se così fosse ricadremmo in ciò che Orwell stesso ha denunciato più volte: il totalitarismo culturale.
Eppure, quando Orwell parla delle motivazioni che lo portano a scrivere non si ferma alla sua esperienza personale. Non dice: “io scrivo per questo motivo”, “ho scritto quest’opera perché…,” ecc. ma: “gli scrittori scrivono per questi motivi”. Un punto di vista che scivola nel totalitarismo. Quando dice: “ciò che ho cercato di fare negli ultimi dieci anni è stato trasformare la scrittura politica in arte” e quando parla del “desiderio di spingere il mondo in una determinata direzione, di cambiare le opinioni degli altri su quale sia il tipo di società per cui vale la pena di lottare”, Orwell scade nella prospettiva dell’arte come veicolo di messaggi pedagogici. Confonde il saggio con il romanzo.
Nel momento in cui Orwell scrive un romanzo, quel testo non può essere trattato come un saggio, ma come racconto, storia, opera d’arte, indipendentemente dalle sue stesse idee. A tal punto che è legittimo che un lettore qualsiasi non desideri trarre alcun particolare insegnamento, ma lo legga solo per il gusto di seguire una storia, o per una semplice fruizione estetica.

La scrittura non insegna nulla
A un’analoga questione, suscitata dal quotidiano francese Liberation nel 1985 agli scrittori di tutto il mondo, Primo Levi rispondeva elencando addirittura nove motivazioni fondamentali dello “scrittore”. Al terzo posto compare questa: “per insegnare qualcosa a qualcuno”.
Di nuovo una motivazione pedagogica. Di nuovo da uno scrittore che ha conosciuto direttamente il totalitarismo e il gulag e lo ha denunciato.
Nell’anno della sua scomparsa Italo Calvino, anche lui chiamato a rispondere alla stessa domanda, in un articolo del 31 marzo 1985 (La Repubblica), critica nei seguenti termini questa visione “pedagogica” dello scrivere:
“Non credo di avere una vocazione pedagogica; diffido di chi ha la pretesa di migliorare il mondo; diffido particolarmente delle mie idee, troppe volte dimostratesi errate; eccetera. Insomma, rispondere a questa inchiesta equivale a entrare in una crisi depressiva”.
Indagare sulle proprie motivazioni a scrivere è interessante. Ma intanto: esistono davvero motivazioni generali o, piuttosto, occorre parlare di motivazioni a scrivere una determinata opera e, di più, determinati punti di una determinata opera? Ammesso che uno scrittore voglia esprimere un messaggio “pedagogico”, che cosa ha fatto di male il lettore per subire questo messaggio ed essere privato della propria libertà di “dialogare con i testi”?
La strada della libertà culturale è sempre lastricata di ostacoli che, a volte, giungono da punti imprevedibili.

L’inesauribile segreto dell’arte
In questa poesia, Il porto sepolto, Mariano il 29 giugno 1916, Giuseppe Ungaretti ci ricorda che scrivere non è qualcosa di realmente comprensibile. Il senso dell’opera sfugge allo stesso autore.
Vi arriva il poeta
e poi torna alla luce con i suoi canti
e li disperde
Di questa poesia
mi resta
quel nulla
d’inesauribile segreto
Il “porto sepolto” non è un solo luogo fisico ma una moltitudine geografica che non si identifica con un preciso punto in una mappa. Può essere l’antico porto sepolto romano, quasi invisibile tra i riflessi del mare di Alessandria d’Egitto, dove è nato e ha vissuto. Oppure il porto sepolto dei caffè di Parigi, fra i futuristi e i cubisti con i quali condivideva le giornate. Può essere il porto sepolto della guerra sul Carso, dove il corpo massacrato dei compagni è disperso a pezzi esattamente come il canto del poeta, mentre il suo è seppellito nell’odore della guerra. Il porto sepolto, in ciascun autore, è un insieme di porti, di luoghi il cui il cui risultato non è più un luogo, ma il proprio porto sepolto, che racchiude un segreto che solo un poeta può cogliere, perché sa aprire la via di quel porto e portare alla luce i suoi canti che però, restano incomprensibile allo stesso autore (“inesauribile segreto”).
Detto in altri termini: l’autore scorge il porto come una specie di destinazione, si tuffa al suo interno per osservare, archeologo estasiato da una civiltà antica che è solo sua, vecchia di millenni, giovane come la sua infanzia ma, alla fine, pur sempre sconosciuta. Si perde nella quiete storica delle antiche colonne, ascolta il rumore e il suono da quel buio profondo e riemerge alla materialità della vita per disperdere questi canti, cioè quello che ha scritto, quello che ha dipinto o scolpito, lo spartito musicale che ha creato… senza capirne l’essenza, che resta misteriosa.
Arte indecifrabile e inconscio
L’opera d’arte non può essere decifrata, può essere solo analizzata e discussa, se ne può solo “parlare”. E non ci deve insegnare nulla. Di più: potrei anche dire che un’opera d’arte che mette tutti d’accordo è un’opera di regime.
Come una cantilena infinita l’autore ricompie ogni volta il tragitto verso l’approdo mobile di un porto che chiama e poi, ogni volta, risale per esprimere il nulla di una catena inesauribile di altri segreti che attendono sui fondali di un porto sepolto in ciascuno di noi.
Questo rapporto fra conscio e inconscio, fra porto sepolto e canti che vengono dispersi senza realmente averne compreso il segreto, è stato così descritto da Sigmund Freud (S. Freud, Casi clinici 5 L’uomo dei Topi, Boringhieri, Torino, 1981, pag.32):
“Per illustrargli alcune brevi osservazioni che gli vengo esponendo sulle differenze psicologiche tra conscio e inconscio, sull’usura cui soggiace tutto ciò che è conscio, mentre l’inconscio è relativamente inalterabile, gli mostro alcune antichità che si trovano nel mio studio. Sono oggetti qualsiasi trovati in una tomba, che in tanto si sono conservati in quanto sono rimasti sepolti sotto terra. Pompei comincia ad andare in rovina solo adesso, da quando è stata dissotterrata.”
Detto in altri termini: nel momento in cui il contatto con quel porto sepolto diventa comprensibile, inizia a perdere il suo “inesauribile segreto” e quindi comincia a decadere e, alla fine, non ci sarebbe opera d’arte. L’arte è quindi il prodotto dell’ignoranza, dell’incomprensione, della mancanza di conoscenza, ma del contatto, vivo e costante, con il proprio inesauribile segreto.

Potere dell’artista, potere di Dio
Non c’è forse dell’ironia in questo atto di creazione incomprensibile, per definizione, all’autore stesso? In questo nucleo segreto “inalterabile”, come dice Freud, molto più resistente della caduca realtà? In una poesia che diventa “universale”, proprio quando gli eventi della vita muoiono?
Giovanni Pascoli, in Merlino (trad. dai Chantes Populaires, riduzione II Merlin-Devin), ci mostra proprio questa ironia dell’arte e autoironia del poeta.
“Merlino, così mattiniero?
dove vai col cane tuo nero?”
iù, iù, u. iù. iù, u
“Qui l’ovo ricerco del drago:
l’ovo rosso: in riva al lago:
il vischio nel bosco, sul fonte;
l’erba d’oro su per il monte”.
“Merlino, convèrtiti! al monte
lascia l’erba, il vischio sul fonte.
E lascia sul greppo del lag
l’ovo rosso, l’ovo di drago.
Merlino! Merlino! Merlino!
Dio è il mago, Dio l’indovino”.
iù, iù, u. iù. iù, u
Infatti Merlino vorrebbe coltivare quella magia che lo lega alla natura e che lo porta all’interno dei misteri, svelandogli i suoi segreti, ma questo è un compito di Dio, non certo dell’uomo. Pascoli ironizza: ma non vorrai mica crederti Dio, mio Grande Artista! Alla fine sei sempre un piccolo uomo che si illude di comprendere i segreti (inesauribili), della vita.
Merlino, cioè l’artista, lo scrittore, il musicista, il regista, il pittore… ha la facoltà di creare nuovi mondi, personaggi, ambienti. L’uovo di drago può essere una rima o un intero mondo, un sito cinematografico, ma tutta la creazione avviene nella sua immaginazione che poi è trasportata in un testo, in un acquarello, in un un suono. Merlino crea mondi fantasiosi che non esistono nella realtà poiché la realtà è stata creata dall’unico vero grande mago, Dio (o la Natura, o l’imperscrutabile, o il caso, dipende da quello in cui credete, ma sicuramente non dall’artista).
È un’ironia, un’ironia su quanto la religione, la morale, le convenzioni, la pedagogia, l’educazione stessa, siano alla fine altrettanti ostacoli alla libertà della ricerca poetica, alla libertà totale dell’arte e dato che, secondo lo stesso Pascoli, in ognuno di noi c’è dell’arte, alla fine si rimanda alla libertà dell’uomo tout court, alla sua capacità di esprimerla in atti creativi.

Libertà dell’arte, libertà dell’artista
Questo concetto ci ricorda anche quel sacerdote che in Baudelaire (Corrispondenze), raffigura il poeta: uomo, sei tu il sacerdote, sei tu il mago, sei tu l’interprete. Però sappi che la natura (nel senso di tutto l’esistente: umano, artificiale, naturale, cosciente, incosciente) è così vasta, misteriosa, “magica”, inesauribilmente segreta, che non puoi metterti al posto di Dio, perché saresti ridicolo…
Eppure, appartenenze religiose a parte, l’unico vero “creatore”, il solo soggetto che possiede le doti magiche della creazione è proprio l’artista. L’artista è il solo a poter rivendicare il potere di Dio, ma senza pensare di essere Dio, conclude Pascoli con grande autoironia.
Senza dimenticare di non aver nulla da insegnare a nessuno, aggiungo io. Per essere creatore devi rinunciare ai panni del maestro, cioè ti devi sbarazzare degli obiettivi della tua opera.
MI ABBONO GRATUITAMENTE A YOUR STORYTELLING
www.albertopian.it ©Alberto Pian – scrivimi: arakhne@mac.com | www.albertopian.it
Your Storytelling è un blog indipendente e non sponsorizzato.