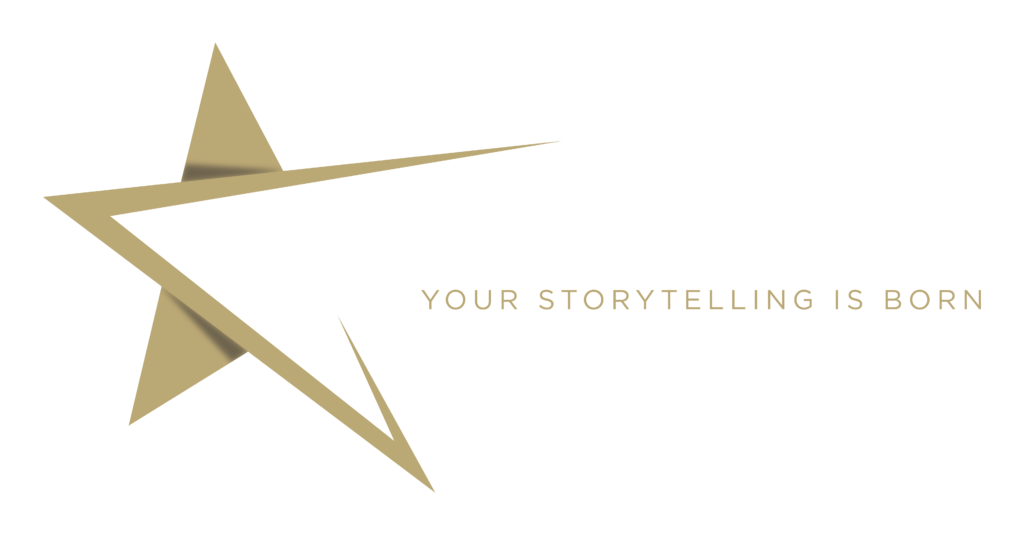Hermann Hesse, 1922. Riferimento: trad. Massimo Mila, Hermann Hesse Romanzi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1977
Cresciuto fra i Brahmini, Siddharta è abituato a vivere con molto distacco dalle cose terrene, a guardarle da una certa distanza e a non farsi coinvolgere dalla realtà:
"Gelido diventava il suo sguardo quando incontrava donne; la sua bocca si contraeva con disprezzo quand'egli doveva accompagnarsi con uomini ben vestiti. Vedeva i mercanti commerciare, i principi andare a caccia, la gnte in lutto piangre i suoi morti, le meretrici far copia di sé, i medici affannarsi per i loro ammalati, i preti stabilire il giorno per la semina, gli amanti amare, le madri cullare i loro bimbi - e tutto ciò non era degno dello sguardo dei suoi occhi, tutto mentiva, tutto puzzava, puzzava dello sguardo di menzogna, tutto simulava un significato di bontà e di bellezza, e tutto era inconfessata putrefazione. Amaro era il sapore del mondo. La vita tormento."
(pag. 670)
Tuttavia Siddharta si sente inquieto, vorrebbe scoprire la verità, indagare l’io e conoscere il rapporto dell’io con il mondo. Per fare questo sente che deve assecondare la propria inquietudine. A rigor di logica il giovane Siddharta non dovrebbe essere inquieto, poiché la sua condizione è quella del sapiente e del saggio, dell’uomo di cultura, addestrato e formato alla conoscenza, alla contemplazione, alla preghiera, quindi dotato di un vasto retroterra culturale e spirituale, che avrebbe dovuto infondere in lui quella sicurezza che, invece, non prova. Siddharta si interroga, però, proprio sul valore di tutto ciò che ha appreso: “Ma valeva la pena saper tutto questo, se non si sapeva l’uno e il tutto, la cosa più importante di tutte, la sola cosa importante?”. Prima di capire quale sia la “sola cosa importante” per un giovane come Siddharta, fermiamoci un momento sul pensiero espresso in queste righe.
Siddharta sembra non attribuire più alcun valore all’insegnamento ricevuto, alla cultura appresa, alle tradizioni che gli sono state tramandate. A che cosa serve tutto questo? A nulla se non si capisce la sola cosa importante che – è questo ciò che viene sottointeso – non si può insegnare.
Si possono insegnare tante cose, si può riempire la testa di un ragazzo di nozioni e di cultura, ma la cosa più importante di tutte è anche la sola che non si può trasmettere. E siccome è la cosa più importante di tutte, tutto quello che si è appreso, per quanto possa essere importante, completo, vasto, in realtà impallidisce, non conta più niente, non ha più alcun valore, di fronte al fatto che non si conosce l’unica cosa che conti davvero. Quale sarebbe dunque questa “cosa”, la sola veramente importante?
In tutto il libro non viene mai menzionata, è la grande assente. Si parla dell’Io, della realtà, della spiritualità, ma questa “cosa” non viene mai definita con precisione, non ci si imbatte in una affermazione sicura, in una chiara formula. Eppure, leggendo il libro, abbiamo la sensazione di sapere con certezza di che cosa si tratta, crediamo di intuirne l’essenza, che ci accompagna per tutto il percorso.
Questa “cosa” misteriosa, in fondo non è altro che l’antica divisa di Delfi: “conosci te stesso”. Se non conosci te stesso, tutto quello che sai sul mondo o sulla religione, sulla materia e sullo spirito, non serve a nulla. Quale posto ha Siddharta nel mondo? Dipende dalla cultura e dalla tradizione che gli vengono tramandate, oppure dalle sue scelte? E se si tratta di scegliere dove collocare il proprio Io, da che cosa è composto, in quali relazioni si trova con il mondo esterno?

Siddharta, come ogni giovane che si affaccia sulla strada della maturità, non sa nulla di tutto ciò e dunque non capisce neppure quale sia il posto a lui riservato nel mondo. Vorrebbe scoprirlo, vorrebbe scoprire quanto è importante il mondo per lui, ma anche quanto lo sia lui stesso per il mondo. Siddharta deve compiere una ricerca, ma questa ricerca sarà sviluppata formalmente nel mondo esterno, attraverso una serie di esperienze, mentre in realtà il suo contenuto, il suo profondo significato è di essere un viaggio alla scoperta di se stessi.
E tuttavia la scoperta di se stessi non può che passare attraverso la conoscenza del mondo e del rapporto che il soggetto intrattiene con la realtà. Conosci te stesso, è dunque la grande insegna che incombe sul giovane Siddharta e che lo spinge al viaggio. Ma è anche la grande insegna di ogni giovane, in tutte le epoche storiche e in tutte le circostanze.
L’inquietudine esistenziale di Siddharta, viene descritta da H. con queste parole:
“L’amore si agitava nel cuore delle giovani figlie dei Brahmini, quando Siddharta passava per le strade della città, con la sua fronte luminosa, con i suoi occhi regali, così slanciato e nobile nella persona.
Ma più di tutti lo amava l’amico suo Govinda, il figlio del Brahmino. Amava gli occhi di Siddharta e la sua cara voce, amava il suo passo e il garbo perfetto dei movimenti, amava tutto ciò che Siddharta diceva e faceva, ma soprattutto ne amava lo spirito, i suoi alti, generosi pensieri, la sua volontà ardente, la vocazione sublime. (…)Così tutti amavano Siddharta. A tutti egli dava gioia, tutti ne traevano piacere. Ma egli, Siddharta, a se stesso non procurava piacere, non era di gioia a se stesso. Passeggiando sui sentieri rosati del frutteto, sedendo nell’ombra azzurrina del boschetto delle contemplazioni, purificando le proprie membra nel quotidiano lavacro di espiazione, celebrando i sacrifici nel bosco di mango dalle ombre profonde, con la sua perfetta compitezza d’atteggiamenti, amato da tutti, di gioia a tutti, pure non portava gioia in cuore. Lo assalivano sogni e pensieri irrequieti, portati fino a lui dalla corrente del fiume, scintillati dalle stelle della notte, dardeggiati dai raggi del sole; sogni lo assalivano, e un’agitazione dell’anima, vaporata dai sacrifici, esalante dai versi del Rig-Veda stillata dalle dottrine dei vecchi testi brahminici. Siddharta aveva cominciato ad alimentare in sé la scontentezza. Aveva cominciato a sentire che l’amore di suo padre e di sua madre, e anche l’amore dell’amico suo, Govinda, non avrebbero fatto per sempre la sua eterna felicità, non gli avrebbero dato la quiete, non l’avrebbero saziato, non gli sarebbero bastati. Aveva cominciato a sospettare che il suo degnissimo padre e gli altri suoi maestri, cioè i saggi Brahmini, gli avevano già impartito il più e il meglio della loro saggezza, avevano già versato interamente i loro vasi pieni nel suo recipiente in attesa, ma questo recipiente non s’era riempito, lo spirito non era soddisfatto, l’anima non era tranquilla, non placato il cuore. Buona cosa le abluzioni, certo: ma erano acqua, non lavavano via il peccato, non guarivano la sete dello spirito, non scioglievano gli affanni del cuore. Eccellente cosa i sacrifici e la preghiera agli dèi: ma questo era tutto? Davano i sacrifici la felicità? E come stava questa faccenda degli dèi? Era realmente Prajapati che aveva creato il mondo? Non era invece l’Atman, l’unico, il solo, il tutto? Che gli dèi non fossero poi forme create, come tu e io, soggette al tempo, caduche? Anzi, era poi bene, era giusto, era un atto sensato e sublime sacrificare agli dèi? A chi altri si doveva sacrificare, a chi altri si doveva rendere onore, se non a Lui, all’unico, all’Atman? E dove si poteva trovare l’Atman, dove abitava, dove batteva il suo eterno cuore, dove altro mai se non nel più profondo del proprio io, in quel che di indistruttibile ognuno porta in sé? Ma dove, dov’era questo lo, questa interiorità, questo assoluto? Non era carne e ossa, non era pensiero né coscienza: così insegnavano i più saggi. Dove, dove dunque era? Penetrare laggiù, fino all’Io, a me, all’Atman; c’era forse un’altra via che mettesse conto di esplorare? Ahimè! questa via nessuno la insegnava, nessuno la conosceva, non il padre, non i maestri e i saggi, non i pii canti dei sacrifici! Tutto sapevano i Brahmini e i loro libri sacri, tutto, e perfino qualche cosa di più; di tutto s’erano occupati, della creazione del mondo; della natura del linguaggio, dei cibi, dell’inspirare e dell’espirare, della gerarchia dei cinque sensi, dei fatti degli dèi… cose infinite sapevano… Ma valeva la pena saper tutto questo, se non si sapeva l’uno e il tutto, la cosa più importante di tutte, la sola cosa importante?
(pag. 662 – 664)
La prima attenzione di Siddharta è rivolta al mondo degli asceti, perché sembra che questi abbiano raggiunto uno stato ideale di armonia interna. Dato che la ricerca di sè, del proprio io e del suo rapporto con l’universo, è lo scopo del viaggio che Siddharta sta per intraprendere, ecco che lo stato di quiete e di armonia raggiunto dagli asceti, attira profondamente Siddharta. Egli dunque ne è affascinato e desidera subito unirsi a loro. Lo farà dimostrando al padre di avere la stessa loro determinazione, di essere fatto della loro stessa materia e del loro stesso spirito, di avere la loro stessa forza. È molto bella questa asserzione, ferma ma delicata allo stesso tempo:
“Allora il padre s’accorse che Siddharta non abitava già più con lui in quella casa: Siddharta l’aveva già abbandonato.”
Il padre, che inizialmente cercò di ostacolare il figlio e che, anzi, dovette calmare la propria rabbia di fronte alla richiesta di Siddharta, non poté fare a meno, di fronte alla fermezza del figlio, di cedere alla sua volontà. Ma, si noti bene, la volontà di Siddharta non era affatto un capriccio, né una forma di opposizione al padre e neppure una manifestazione narcisista di affermazione di sè. No, quella di Siddharta era la ferma volontà di cercare se stesso e, dato che “se stesso” non era più in quella famiglia e neppure in quel luogo, la sua esperienza, in famiglia e in quei luoghi, era finita, era percepita da Siddharta come conclusa.
Non sentendosi più lì Siddharta si sentiva già altrove, il suo Io, la sua anima, il suo stesso corpo erano in un altro luogo, come suo padre aveva benissimo percepito, dopo averlo messo alla prova. La prova di Siddharta di fronte al padre non ha lo scopo di dimostrare quanta fermezza e determinazione avesse Siddharta. Né a Siddharta, né a suo padre interessava misurare la ferma volontà del figlio in termini quatitativi: quanto digiuno sarebbe stato disposto a sopportare, quanta fatica. La prova a cui Siddharta si sottopone e alla quale il padre lo sperimenta, serviva solo per capire fino a che punto Siddharta non abitasse più lì, quanto fosse ormai distante dalla famiglia, quanto fosse lontano dalla tradizione, dalla cultura del padre, fino a che punto fosse ormai definitivamente altrove. Scoperto che tutto (tranne il suo corpo, che continuava a patire le pene di questa prova, attendendo in piedi e a digiuno, una risposta dal padre), fosse in realtà già definitivamente “altrove”, non restava che permettere al corpo di Siddharta di ricongiungersi al suo spirito. Per questo il testo dice: “Allora il padre s’accorse che Siddharta non abitava già più con lui in quella casa: Siddharta l’aveva già abbandonato.”
Qui abbiamo anche una prova della saggezza e dell’umanità del padre. Certo, egli avrebbe desiderato che Siddharta proseguisse il cammino tracciato per lui dalla famiglia. Certo, inizialmente il padre deve reprimere un moto di rabbia, ma poi accetta la prova del figlio e ne trae la giusta lezione. Lo lascia partire con il suo consenso, non perché il figlio se ne vuole andare ed è fermo nel suo proposito, ma perché è già da un’altra parte, se n’è già andato, è altrove, perché, in definitiva, la sua strada sarà un’altra e suo padre lo capisce.

Questa lezione sarà anche quella conclusiva del libro. Siddharta avrà un figlio e questo figlio lo lascerà. Ogni soggetto ha diritto a ricercare il proprio Io, a scegliere la propria strada, a sperimentare le proprie esperienze, nessuna esclusa, se il fine è quello di cercare se stessi. Ognuno, in altri termini, ha diritto al proprio Io, al proprio “sè”, ad essere un soggetto per sè, ha diritto alla sua indipendenza, che non può che essere il frutto di una ricerca personale. Se questa ricerca è sincera, cioè se non è dettata dal rancore, dalla gelosia e dall’invidia, dalla contrapposizione nei confronti del padre o dei genitori, oppure dalla subordinazione, dalla dipendenza nei confronti di altri, ma è sincera perché nasce, matura e si sviluppa al proprio interno, come un moto autonomo, sorretto dal proprio istinto e dal proprio desiderio profondo, perché ostacolarla? perché impedirla?
Il padre di Siddharta non ostacola, mette alla prova per capire e quando capisce che, effettivamente, Siddharta è già “altrove” e lo è per sè, in modo onesto, sincero e cristallino, non può che acconsentire, poiché in fondo Siddharta risponde, con il suo gesto, anche agli stessi valori del padre, rivolti alla scoperta e alla pienezza del soggetto e non alla sua fustigazione e limitazione. Quindi possiamo anche cogliere l’orgoglio e l’ammirazione del padre nei confronti del figlio, che traspare dalle righe, ma che non si manifesta apertamente. L’accettazione paterna è così piena e perfetta che, in effetti, ci illumina anche sull’ammirazione che il padre prova, a questo punto, nei confronti del figlio. Ecco il testo:
"Il padre posò la mano sulla spalla di Siddharta «Andrai nella foresta», disse «e diverrai un Samana. Se nella foresta troverai la beatitudine, ritorna, e insegnami la beatitudine. Se troverai la delusione, ritorna: riprenderemo insieme a sacrificare agli dèi. Ora va' a baciar tua madre, dille dove vai. Ma per me è tempo d'andare al fiume e di compiere la prima abluzione.» Tolse la mano dalla spalla di suo figlio, e uscì."
La parte significativa è questa: “Ora va’ a baciar tua madre, dille dove vai.” Invitando Siddharta a baciare la madre e a dirle dove sarebbe andato, il padre sembra conferire non solo il proprio appoggio al figlio, ma sembra anche fornirgli la propria stessa adesione, la sua ammirazione, per la decisione presa. Siddharta, agli occhi del padre è un uomo e un uomo deve andare per la sua strada e comportarsi da uomo. Il saluto, attraverso un bacio e la parola esplicativa, ma allo stesso tempo definitiva, rivolta alla madre, sanciscono il distacco, un distacco sul quale non c’è nulla da dire. Tu sei cresciuto, Siddharta, sei maturato, sei uomo, andrai per la tua strada. Io di questo sono fiero, la mia missione educativa nei tuoi confronti è compiuta, puoi andare e puoi congedarti da noi, il tuo congedo lo offrirai a tua madre, che ti ha portato in grembo e ti ha accudito e cresciuto, la bacerai e le parlerai perché lei deve sapere che quello che ha fatto lo ha fatto bene, dato che tu ora sei un uomo e te ne devi andare.
Infine, su questa parte iniziale del romanzo, voglio esprimere un’altra considerazione, sul tema del viaggio. Il viaggio di Siddharta alla ricerca di se stesso, non inizia dal basso, ma dall’alto. Di solito, per compiere un viaggio introspettivo, il soggetto attraversa una serie di esperienze concrete, dapprima molto misere e “basse”, per poi, poco per volta, ascendere a livelli spirituali più elevati. Di solito il viaggio consiste in una specie di purificazione dell’anima dai livelli più infimi fino a raggiungere gli stadi più elevati e più puri. Per Siddharta sarà esattamente l’opposto. Egli incomincerà dall’ascesi spirituale più assoluta per poi scendere i gradini della vita e del mondo fino a convivere con una prostituta, a dedicarsi al commercio, a sperperare ricchezze al gioco e farsene coinvolgere. Ma, intanto, è nei confronti dei Samana che Siddharta esprime tutta sua ammirazione e ritiene che presso di loro ci sia la chiave, la risposta che cerca.
“E un giorno passarono i Samana attraverso la città di Siddharta: asceti girovaghi, tre uomini secchi e spenti, né vecchi né giovani, con spalle impolverate e sanguinose, arsi dal sole, circondati di solitudine, estranei e ostili al mondo, forestieri nel regno degli uomini come macilenti sciacalli. Spirava da loro un’aura di cheta passione, di devozione fino all’annientamento, di spietata rinuncia alla personalità. A sera, dopo l’ora dell’osservazione, Siddharta comunicò a Govinda: « Domani mattina per tempo, amico mio, Siddharta andrà dai Samana. Diventerà un Samana anche lui ». A queste parole Govinda impallidì, e nel volto immobile dell’amico lesse la decisione, inarrestabile come la saetta, scagliata dall’arco. Subito, al primo sguardo, Govinda si rese conto: ora comincia, ora trova Siddharta la sua via, ora comincia il suo destino a germogliare, e con il suo il mio. E divenne pallido, come una buccia di banana secca.
« O Siddharta », esclamò « te lo permetterà tuo padre? » Siddharta sollevò lo sguardo, come uno che si ridesta. Fulmineamente lesse nell’anima di Govinda: vi lesse la paura, vi lesse la dedizione. «O Govinda », rispose sommessamente « è inutile sprecar parole. Domani all’alba comincerò la vita del Samana. Non parliamone più. » Siddharta entrò nella camera dove suo padre sedeva sopra una stuoia di corteccia, s’avanzò alle sue spalle e rimase là, fermo, finché suo padre s’accorse che c’era qualcuno dietro di lui. Disse il Brahmino: « Sei tu, Siddharta? Allora di’ quel che sei venuto per dire ». Parlò Siddharta: «Col tuo permesso, padre mio. Sono venuto ad annunciarti che desidero abbandonare la casa domani mattina e recarmi fra gli asceti. Diventare un Samana, questo è il mio desiderio. Voglia il cielo che mio padre non si opponga ». Tacque il Brahmino:’ tacque così a lungo che nella piccola finestra le stelle si spostarono e il loro aspetto mutò, prima che venisse rotto il silenzio nella camera. Muto e immobile stava ritto il figlio con le braccia conserte, muto e immobile sedeva il padre sulla stuoia, e le stelle passavano in cielo. Finalmente parlò il padre: « Non s’addice a un Brahmino pronunciare parole violente e colleriche. Ma l’irritazione agita il mio cuore. Ch’io non senta questa preghiera una seconda volta dalla tua bocca». Il Brahmino si alzò lentamente; Siddharta restava in piedi, muto, con le braccia conserte. « Che aspetti? » chiese il padre. Disse Siddharta: « Tu lo sai ». Irritato uscì il padre dalla stanza, irritato cercò il suo giaciglio e si coricò. Dopo un’ora, poiché il sonno tardava, il Brahmino si alzò, passeggiò in su e in giù, uscì di casa. Guardò attraverso la piccola finestra della stanza, e vide Siddharta in piedi, con le braccia conserte: non s’era mosso. Come un pallido bagliore emanava dal suo mantello bianco. Col cuore pieno d’inquietudine, il padre ritornò al suo giaciglio. E venne di nuovo dopo un’ora, venne dopo due ore, guardò attraverso la piccola finestra, vide Siddharta in piedi, nel chiaro di luna, al bagliore delle stelle, nelle tenebre. E ritornò ogni ora, in silenzio, guardò nella camera, vide quel ragazzo in piedi, immobile, ed il suo cuore si riempì di collera, il suo cuore si riempì di disagio, il suo cuore si riempì d’incertezza, il suo cuore si riempì di compassione. Ritornò nell’ultima ora della notte, prima che il giorno spuntasse, entrò nella stanza, vide il giovane in piedi, e gli parve grande, quasi straniero. « Siddharta », chiese «che attendi? » « Tu lo sai. » « Starai sempre così ad aspettare che venga giorno, mezzogiorno e sera? » «Starò ad aspettare. »
« Ti stancherai, Siddharta. » « Mi stancherò. » « Ti addormenterai, Siddharta. » « Non mi addormenterò. » «Morirai, Siddharta.» « Morirò. » «E preferisci morire, piuttosto che obbedire a tuo padre? » « Siddharta ha sempre obbedito a suo padre. » « Allora rinunci al tuo proposito? » « Siddharta farà ciò che suo padre gli dirà di fare. »
Le prime luci del giorno entravano nella stanza. Il Brahmino vide che Siddharta tremava leggermente sulle ginocchia. Nel volto di Siddharta, invece, non si vedeva alcun tremito: gli occhi guardavano lontano. Allora il padre s’accorse che Siddharta non abitava già più con lui in quella casa: Siddharta l’aveva già abbandonato. Il padre posò la mano sulla spalla di Siddharta « Andrai nella foresta », disse « e diverrai un Samana. Se nella foresta troverai la beatitudine, ritorna, e insegnami la beatitudine. Se troverai la delusione, ritorna: riprenderemo insieme a sacrificare agli dèi. Ora va’ a baciar tua madre, dille dove vai. Ma per me è tempo d’andare al fiume e di compiere la prima abluzione. » Tolse la mano dalla spalla di suo figlio, e uscì. Siddharta barcollò, quando provò a muoversi. Ma fece forza alle sue membra, s’inchinò davanti al padre andò dalla mamma, per fare come suo padre aveva prescritto. Quando alle prime luci del giorno, lentamente, con le gambe indolenzite, lasciò la città ancora silenziosa, un’ombra, ch’era accucciata presso l’ultima capanna, si levò e s’unì al pellegrino: Govinda. « Sei venuto» disse Siddharta, e sorrise. « Sono venuto » disse Govinda.
(pag. 666 – 669)
Dopo aver vissuto a lungo con i Samana, Siddharta giungerà alle seguenti conclusioni:
“di tutti i Samana che esistono non uno, io credo, neanche uno, raggiunge il nirvana. Troviamo conforti, troviamo da stordirci, acquistiamo abilità con le quali cerchiamo d’illuderci. Ma l’essenziale, la strada delle strade non la troviamo”. (pag. 674 – 675). La sua ricerca deve continuare. Siddharta parla di trovare la “strada delle strade”.
È un’affermazione che suona molto impegnativa, una meta che, fin dalle sue premesse, sembra già di per sè impossibile da realizzare. La “strada delle strade”, l’assoluto, il perfetto, la verità, implicano un insuccesso intrinseco. Ne è consapevole Siddharta? Probabilmente si, perché egli ha già intrapreso strade elevatissime: quella dei Brahmini, quella dei Samana, senza contare i libri sacri sui quali ha studiato. Egli ha già percorso strade difficili ed esclusive, che non è da tutti percorrere, nel campo della ricerca spirituale, della meditazione, della religione. Però c’è ancora qualcosa di più assoluto e perfetto, ci dice Siddharta, esiste una “strada delle strade”, un livello superiore ma indefinito. Forse impossibile da raggiungere. Se fosse impossibile imboccare la “strada delle strade”, allora non lo scopo, ma il viaggio stesso, sarebbe il fine del viaggio. Il valore del viaggio si troverebbe nel viaggio stesso. È il viaggio lo scopo, il fine del viaggio non è altro che il viaggio. È attraverso il viaggio, la ricerca, che ci si può conoscere, tornando al punto di partenza, ma a un diverso livello. Infatti Siddharta alla fine del libro tornerà ai rapporti fra padre e figlio, ma questa volta sarà lui il padre e ripercorrerà la medesima esperienza: dell’allontamento del figlio, dell’amore paterno, dell’educazione e della libertà, in un contesto diverso. In ogni caso parlando di “strada delle strade” Siddharta sembra ancora nutrire l’illusione di poter giustificare il proprio viaggio, seppur attribuendogli uno scopo irraggiungibile.
A un certo punto Siddharta dice:
“Lungo tempo ho imparato, Govinda, e non ne sono ancora venuto a capo, per imparare questo: che non si può imparare nulla! Nella realtà non esiste, io credo, quella cosa che chiamiamo “imparare”. C’è soltanto, o amico, un sapere, che è ovunque, che è Atman, che è in me e in te e in ogni essere. E così comincio a credere: questo sapere non ha nessun peggior nemico che il voler sapere, che l’imparare.” (pag. 675).
Il voler sapere, il voler imparare è nemico dell’imparare stesso. È naturale poiché ciò che Siddharta vorrebbe imparare è il segreto della vita stessa, della sua vita, è l’intima conoscenza di sè, che dovrebbe stabilire l’armonia completa con il mondo circostante. Questo genere di apprendimento non si acquisisce solo perché lo si vuole acquisire. È il frutto dell’esperienza e quindi occorrerebbe imboccare diverse strade e cambiare percorso ogni volta che ci si accorge che quella che si sta percorrendo ha esaurito la sua primaria fonte di conoscenza. La ricerca stessa diventa fonte di apprendimento.
La sua posizione: “sono diventato diffidente e stanco verso le dottrine e verso l’apprendere, e scarsa è la mia fede nelle parole che ci vengono dai maestri” (pag. 678) è di nuovo un invito alla ricerca permanente. E sarà una ricerca permanente, perché, anche ormai vecchio e dolente, ripartirà ancora una volta, in viaggio, per inseguire suo figlio. Salvo capire che non può pretendere che suo figlio rinneghi ciò che lui stesso ha seguito per tutta la vita e cioè viaggiare alla ricerca di sè.

Lungo il suo percorso, Siddharta incontra un essere effettivamente “perfetto”, un soggetto che ha raggiunto la pace interna, la sicurezza e il consolidamento del suo Io (o l’annullamento, se si preferisce, nel libro Siddharta parla di annullamento dell’Io, nel senso di stabilire una compenetrazione fra sè e il mondo circostante). Quest’uomo è il Budda, che appare a Siddharta “nella perfezione della sua calma, alla tranquillità della sua immagine, in cui non v’era ricerca, non vi era desiderio, non aspirazione, non sforzo, ma solo luce e pace” (pag. 683).
Quindi la ricerca deve sfociare nella scomparsa dello stimolo della ricerca stessa. Lo scopo del viaggio sembra sia dunque quello di mettere fine al viaggio. Lo scopo del desiderio è mettere fine al desiderio. La “strada delle strade” consiste nel riuscire a trovare una pace spirituale in se stessi, che stabilisca anche una pace con il mondo sterno, una sorta di assenza di conflitti. È evidente che ciò risulta impossibile, il conflitto è parte integrante della natura umana, sia il conflitto fra l’uomo e la natura che i conflitti interni, dovuti alla repressione delle pulsioni, alla lotta permanente fra la natura selvaggia dell’uomo, il suo “stato naturale” e il vivere in società, il dover addomesticare questo stato, convogliarlo verso la convivenza. Forse possiamo intendere questo episodio anche in un altro modo, possiamo cioè supporre che la “quiete” a cui si riferisce Siddharta non consista nel negare la natura umana, oppure nell’idealizzare la possibilità di raggiunge uno stato di quiete, ma nel saper governare e indirizzare consapevolmente la natura umana, la propria natura, e nel saper gestire i propri conflitti interni ed esterni con serenità. La conoscenza di sè, potrebbe determinare nel soggetto quella disposizione d’animo, quella “serenità” che lo porterebbe a non essere una inconsapevole preda delle emozioni, specialmente inconsce e quindi a saperle governare, a saperci giocare, a essere saldo nel proprio Io. Ma, ancora una volta: si può forse imparare questo? Lo si può forse insegnare? È questa la pretesa del Budda: insegnare agli altri come ha raggiunto questo stato, supponendo che la propria esperienza sia universale e che ogni soggetto possa compiere lo stesso cammino del Budda e giungere alla stessa meta. Ciò equivarrebbe a sostenere che l’esperienza personale di ciascun soggetto non conterebbe nulla ai fini della sua stessa conoscenza di sè. E vorrebbe anche dire che ogni soggetto non dovrebbe compiere nella vita esperienze diverse e imboccare strade diverse, poiché una sola esperienza e una sola strada sarebbero quelle che conducono a questa meta: l’esperienza e la strada del Budda. Infatti, Siddharta parla in questo modo al Budda:
"Tu hai trovato la liberazione dalla morte. Essa è venut a te attraverso la tua richezza, ti è venuta incontro sulla tua stessa strada, attraverso il tuo pensiero, la concentrazione, la conoscenza, la rivelazione. Non ti è venuta attraverso la dottrina! (...) nessuno perverrà mai liberazione attraverso una dottrina! A nessuno, o venerabile tu potrai, con parole, e attraverso una dottrina, comunicare ciò che avvenne in te nell'ora della tua illuminazione!" (pag. 688).
L’esperienza personale non può essere codificata in una dottrina. Non si apprende l’esperienza attraverso una dottrina, senza la propria esperienza anche la dottrina non può nulla. Il Budda ha percorso una sua strada e Siddharta compirà la propria.
A questo punto ha capito definitivamente che deve abbandonare qualsiasi dottrina per vivere nel mondo reale, per gettarsi a capofitto nelle esperienze della vita:
"Dal mio stesso Io voglio andare a scuola, voglio conoscermi, voglio svelare quel mistero che ha nome Siddharta" (...) "io che volevo leggere il libro del mondo e il libro del mio proprio Io, ho disprezzato i segni e l lettere, a favore d'un significato congetturato in precedenza, ho chiamato illusione io mondo delle apparenze, ho chiamato il mio occhio e la mia lingua fenomeni accidentali e senza valore. No, tutto questo è finito, ora son desto, mi sono risvegliato nella realtà e oggi nasco per la prima volta" (pag. 692 - 693).
Siddharta decide quindi di vivere nella realtà e comincia dal gradino più basso: si rivolge a una prostituta per capire come funziona l’amore, per imparare a vivere. La prostituta gli dirà che per avere i suoi insegnamenti, Sidharta deve avere dei soldi, un bel vestito e delle belle scarpe e quindi dovrà trafficare e lavorare. Siddharta diventa quindi mercante a servizio di un mercante. Dapprima tutto ciò che aveva imparato, come lui stesso dichiara, ovvero digiunare, meditare, aspettare, gli sono di grande aiuto: mentre il mercante va in collera facilmente, è un umano preda dei sentimenti, delle proprie ansie e angosce, della mancanza di conoscenza di sè, Siddharta appare calmo e tranquillo in ogni circostanza e, per questo, gestisce bene il lavoro ed è apprezzato e guadagna molto. Ma, un po’ per volta, la natura religiosa e ascetica che c’era in lui si perde, la sua bella anima si sporca a contatto con le bassezze del mondo e lui stesso diventa dipendente dal vizio del gioco. Naturalmente un giorno se ne accorge e decide nuovamente di cambiare vita, di tornare alla semplicità e all’essenziale, a diretto contatto con la natura. Siddharta andrà a svolgere il mestiere di barcaiolo presso un altro barcaiolo. Con lui vivrà nel fiume, parlerà al fiume, interrogherà il fiume. Mangerà poche cose ricavate dal bosco e dai campi e non possederà più nulla.
L’esperienza di Siddharta mercante, giocatore e anche studente in amore presso una prostituta, indica in modo molto chiaro che la realtà, quando è vissuta fino in fondo è più forte di qualsiasi barriera culturale, di qualsiasi apprendimento precedente. Se si vuole apprendere realmente dalla vita occorre mettere in gioco innanzitutto la propria. Siddharta dà alla vita tutto se stesso, così come l’aveva dato ai Brahmini e ai Samana.

Non rinuncia mai a vivere un’esperienza fino in fondo, non ne ha timore. Perché? Perché, evidentemente, ha maturato una grande forza interna, capace di proteggerlo al momento opportuno, capace di aiutarlo, anche nel corso di un’esperienza concreta, per quanto “bassa” e pericolosa possa essere, a ricavare le lezioni necessarie, senza farlo capitolare di fronte all’esperienza stessa. Siddharta diventa giocatore, ne assume i connotati, si piega al vizio, ma solo per apprendere direttamente dall’esperienza, non per farsene schiacciare e, al momento opportuno, lascia di nuovo tutto e riparte.
“Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente, in una disposizione di spirito infantile” (pag. 699).
Questa disposizione infantile è tutt’altro che infantile.
Se lo fosse davvero Siddharta soccomberebbe al mondo e alle esperienze che è chiamato ad affrontare. Siddharta ha raggiunto questo stato di semplicità d’animo, di apertura e disposizione agli aventi, non perché è un fanciullo, ma precisamente perché il suo Io si è rafforzato, perché la forza è in sè e non nelle cose terrene che non lo potranno scalfire. Siddharta può aprirsi all’esperienza con animo “infantile” perché egli stesso è più forte dell’esperienza, della vita stessa, perché la sa governare, perché nel suo intimo sa quale strada deve prendere, sa perfettamente quale sia la “strada di tutte le strade”, poiché dentro di sè ha maturato la propria forza.
Questo è lo scopo di Siddharta, ma egli non sa di averlo raggiunto, non conosce ancora se stesso, non sa che decidere di dedicarsi completamente a un’esperienza e al momento opportuno lasciarla per cercare altre strade, senza aver causato danni in se stessi, significa aver raggiunto una meta, forse la meta della vita stessa. Egli agisce, guidato da un istinto e non sa che quell’istinto è il frutto del suo equilibrio interno, è il suo Io che gli parla, non sa di essere nella stessa condizione del Budda che a suo tempo aveva incontrato. Prima di avere le sue esperienze come commerciante e con la prostituta, Siddharta pensava che avrebbe trovato il suo Io a contatto con la vita concreta e con le esperienze del mondo.
In realtà l’Io di Siddharta esisteva già da tempo, fin da quando decise di comunicare a suo padre la decisione di partire con i Samana. È lì che l’Io di Siddharta si è manifestato in tutta la sua costituzione e forza. Egli però non lo sapeva. E adesso, ancora, non sa che cosa sia l’Io. Pensa di non averlo trovato mai davvero:
"Ma mai aveva realmente trovato questo Io, perché aveva voluto pigliarlo con la rete del pensiero. Anche se il corpo non era certamente quest'Io, e non lo era il gioco dei sensi, però non era l'Io neppure il pensiero, non l'intelletto, non la saggezza acquisita, non l'arte appresa di trarre conclusioni e dal già pensato dedurre nuovi pensieri" (pag. 701).
L’Io di Siddhrata esisteva, invece e aveva dato prova della sua forza al cospetto del padre. Il padre però lo aveva capito, aveva riconosciuto che Siddharta era altrove. Ma questo altrove non indicava tanto il fatto che il ragazzo fosse già con i Samana, quanto il fatto che fosse in un altro luogo topico, non più presso l’ “Io” famigliare, se così si può dire, ma presso il proprio Io, presso se stesso, perché Siddharta stava ascoltando la sua stessa voce, la voce dell’Io provenire dal suo interno e si accingeva a seguirla.
In quel momento, però, Siddharta non riconosce il suo Io, confonde il proprio Io con quello dei Samana, la voce del proprio io con il richiamo degli asceti. E dopo tanti anni, dopo tutte le sue esperienze, Siddharta ignorerà ancora una volta dove si trovi il suo Io, pur avendolo in effetti seguito in tutto questo tempo e in tutte queste vicende.
Egli non lo riconosce, continua a non riconoscerlo. Non riesce a capire che cosa sia: non è corpo ma è corpo, non è pensiero, ma è pensiero, non è gioco dei sensi, come dice, ma con i sensi deve pur averci a che fare. Il mistero dell’Io risiede nel fatto che non esiste concretamente, non assume alcuna sembianza organica e non possiede un luogo nel quale risiede, ma esiste come un tutto che si presenta attraverso l’unità di ciò che il soggetto è: pensiero, corpo, sensi, pulsioni. E come tale va riconosciuto. E se l’Io è integro e viene riconosciuto nella sua integrità, la sua voce sarà forte e sarà il frutto dell’unità e di tutto ciò che il soggetto è. Invece, se l’Io è diviso, frantumato, in preda a conflitti, dilaniato, incerto, debole, sottomesso, succube, calpestato, si presenterà al soggetto come debole, incerto, malato, privo di unità, scoordinato nei suoi elementi costitutivi.
L’Io di Siddharta è tutto ciò che Siddharta è: il corpo, i sensi, il pensiero… ma Siddharta ne è ancora alla ricerca, egli non vede ciò che ha sotto il naso. Forse Siddharta è frenato nella conoscenza di se stesso perché non è consapevole della propria forza interiore, forza che lo spinge ancora a cercare. Forse Siddharta deve espiare una colpa e per questo continua a ignorare il suo forte Io che gli parla, lo protegge e lo guida.
Forse è per questo che sceglie una prostituta come insegnante d’amore e non una donna comune, forse il cammino della sua espiazione passa attraverso la degradazione. Che Siddharta abbia provato un amore così sublime ed elevato, ma altrettanto impossibile da concretizzare, da dover passare per gli insegnamenti di una meretrice?
È curioso che alla sua amante, Kamala, Siddharta dica quanto segue:
"La maggior parte degli uomini, Kamala, sono come una foglia secca, che si libra e si rigira nell'aria e scende ondeggiando al suolo. Ma altri, pochi, sono come le stelle fisse, che vanno per un loro corso preciso, e non c'è vento che li tocchi, hanno in se stessi la loro legge e il loro cammino. " (pag. 721).
Senza rendersi conto di essere lui stesso una “stella fissa”, un uomo che segue la sua voce. E che cos’altro avrebbe seguito fino a ora Siddharta? Egli dunque non riconosce il suo Io. Non sa da che parte collocarsi, nel genere umano. Egli pensa questo degli uomini:
"Tutti sono riconoscenti, mentre avrebbero essi stessi diritto alla riconoscenza. Tutti sono sottomessi, tutti desiderano esere amici, desiderano obbedire e penare meno che si può. Bambini sono gli uomini" (ib. pag. 703), ma, allo stesso tempo, non è in grado di collocare se stesso: forse anche Siddharta è un uomo - bambino? No, certamente, di questo ne è consapevole (infatti Siddharta vedeva questi uomini - bambini: "soffrire e farsi i capelli grigi per cose che a lui parevano di nessun conto: denaro, piccoli piaceri, piccoli onori, e li vedeva litigarsi e accapigliarsi, li vedeva lamentarsi di dolori sui quali il Samana sorride, e soffrire per privazioni di cui il Samana nemmeno s'accorge", (pag. 919).
Ma allora che cos’è Siddharta esattamente? È Siddharta stesso a non saperlo. E dopo essersi lasciato catturare dai “piaceri” e dai “dispiaceri” della vita, dopo essere diventato un giocatore d’azzardo che soffriva e si disperava come tutti, avendo perso completamente le sue doti di Samana, di asceta, non essendo più capace di “pensare, aspettare e digiunare”, Siddharta si affida di nuovo all’istinto: “nessun valore e nessun senso aveva la vita da lui condotta fino allora” (pag. 728).
ppure, nemmeno presso il fiume, dove andrà a vivere insieme a un altro barcaiolo, Siddharta saprà riconoscere il proprio Io. Anzi, le lezioni che trae da tutta a lunga vicenda con l’amante prostituta e come mercante e giocatore, è ben poca cosa: “È bene, pensava, sperimentare personalmente tutto ciò che si ha bisogno di sapere. Che i piaceri mondani e la ricchezza non siano un bene, questo lo avevo già imparato da bambino. Saperlo, lo sapevo già da un pezzo; ma vederlo l’ho vissuto soltanto ora” (pag. 741 – 742).
Ben misera e scontata lezione ricava Siddharta da queste tre esperienze con la vita cruda! Egli ha incontrato il proprio Io e non l’ha ancora riconosciuto. Così ora Siddharta lo cerca presso il fiume. Scoprirà che il fiume ha moltissime voci: “Non è vero amico che il fiume ha molte, moltissime voci? Non ha la voce di un re, e quella di un guerrigliero, e quella ‘un toro, e d’un uccello notturno…” (ib. pag. 750). Si potrebbe indicare metaforicamente che dunque esistono diversi Io, che ogni soggetto deve saper guardare al proprio, coltivarlo, scoprirlo e non cercare un Io, una verità, assoluta, una “strada di tutte le strade”. Siddharta sa perfettamente questo.

All’amico barcaiolo suggerisce che tutte voci del fiume, quando parlano insieme, indicano il sacro “Om”, la parola di tutte le parole. L’Io del mondo, l’Om sacro, è formato dall’Io di tutti gli esseri, ma Siddharta non sa collocarsi all’interno dell’Om, lo sa ascoltare, ma non riesce a ritrovarcisi, poiché non conosce il suo posto nell’universo. E così la ricerca continua, questa volta senza più spostarsi, sempre lungo i fiume, meditando, conversando, trasportando persone da una sponda all’altra.
A un certo punto Siddharta incontra suo figlio, portato dalla sua amante che muore colpita da un serpente. Egli deve dunque educare il figlio e lo farà senza educarlo davvero, senza insegnarli nulla, senza imporgli niente, senza mai contrapporsi a lui, sempre lasciandolo libero. Siddharta, che non riconosce il proprio Io, non è in grado di mostrarlo a suo figlio eppure lo mostra, poiché quello è il suo Io. La sua educazione è assente poiché egli stesso non è giunto a nessuna conclusione. Ecco che cosa osserva l’amico barcaiolo che rappresenta un po’ la voce della coscienza:
"Tu non lo costringi, non lo picchi, non gli dai ordini, perché sai che c'è più forza nel molle che nel duro, sai che l'acqua è più forte che la pietra, che l'amore è più forte che la violenza. Molto bene, ti lodo. Ma non ti sbagli forse, credendo di non costringerlo, di non castigrlo? Non lo leghi tu forse in catens con il tuo amore? Non lo svergogni ogni giorno e non gli rendi la vita ancor più dura con la tua bontà e con la tua pazienza? Non lo costringi forse a vivere, lui, un ragazzo orgoglioso e viziato, in una capanna con due vecchi mangia - banane, per i quali il riso è giù una leccornia, i cui pensieri non possono essere i suoi, il cui cuore è vecchio e calmo e ha un altro passo che è il suo? Tutto questo non è forse costrizione, castigo, per lui?" (ib. pag. 759) (...) "Dunque tu credi proprio d'aver commesso le tue follie per risparmiarle a tuo figlio? E puoi forse proteggere tuo figlio dalla samsara? In che modo? Con la dottrina, cone le preghiere, con l esortazioni? Caro mio, hai dunque interamente dimenticato quella storia, quella istruttiva stori di Siddharta, il figlio del Brahmino, che tu mi raccontasti proprio qui, in questo stesso posto? Chi ha protetto il Samana Siddharta dalla samsara, dal peccato, dall'avidità, dalla stoltezza? (...) Quale padre, quale maestro ha potuto proteggerlo da questa ncessità i vivere egli stesso la sua vita, di caricarsi egli stesso la sua parte di colpe, di bere egli stesso l'amaro calice, di trovare egli stesso la sua vita?" (pag. 760).
Siddharta non riusciva a vedere nella sua esperienza, la stessa di suo figlio, il desiderio di cambiare, di cercare, di trovare la propria strada. Siddharta non aveva capito che il suo Io lo aveva condotto via dalla famiglia e in giro per il mondo, esattamente come l’Io di suo figlio lo avrebbe portato via da lui. Siddharta era ancora alla ricerca e non aveva capito che in gioco, fra lui e suo figlio, c’erano i due Io che si misuravano e che l’Io del figlio, di fronte a quell’Io plastico, liquido, indecifrabile, del padre, si chiedeva dove potesse mai abitare.
Siddharta offriva al figlio un’educazione senza limiti, una non – educazione. Ma senza limiti, cioè senza i limiti dell’Io del padre, come poteva misurarsi, formarsi, crescere, l’Io del figlio? Per crescere aveva bisogno di confrontarsi con dei limiti precisi, con i limiti di altri Io, delle loro leggi e con la legge della società.
Per questo il figlio di Siddharta doveva andarsene in città, doveva andare via, per poter trovare i limiti con i quali confrontarsi, gli altri Io che avrebbero aiutato il proprio a delimitarsi, a formarsi, a crescere. Per lo stesso identico motivo Siddharta, a suo tempo, aveva lascito la casa paterna per i Samara. Siddharta riflette:
"Non aveva sofferto anche suo padre della stesa pena di cui egli soffriva ora per suo figlio? Non era morto in solitudine suo padre da tanto tempo, senz'averlo più rivisto? Non doveva egli stesso attendersi questo destino?Non era una commedia, una strana e sciocca faccenda questo correre dietro in un cerchio fatale?" (pag. 769).
È solo a questo punto, dopo aver ritrovato e perso il figlio, dopo aver rivissuto la sua antica esperienza, ma questa volta dalla parte del padre, che Siddharta ha finalmente trovato la sua strada e ne è consapevole:
"In quell'ora Siddharta cessò di lottare contro il destino, in quell'ora cessò di soffrire. Sul suo volto fioriva la serenità del sapere, cui più non contrasta alcuna volontà, il sapere che conosce la perfezione, che è in accordo con il fiume del divenire, con la corente dell vita, un sapere che è pieno di compassione e di simpatia, docile al flusso degli eventi, aderente all'Unità." (pag. 773).
Dunque Siddharta diventa “perfetto”. Diventa “Budda”, come il Budda che aveva a suo tempo incontrato. L’amico barcaiolo ne riconosce il mutamento, che è evidente. Siddharta ha compiuto dunque il viaggio solo ora, alla fine della sua vita, nella vecchiaia. Ha vissuto molte esperienze, ma solo una si è rivelata decisiva, forse la meno cercata e la meno importante di tutte: quella di essere stato per un periodo con suo figlio e di averlo visto ripartire.
Non sono stati i Brahmini o i Samana, neppure i mercanti e le prostitute o i giocatori, i budda e i barcaioli ad aver determinato in lui questo cambiamento, ma solo ed unicamente la ripetizione di un’antica esperienza, specularmente rivissuta, come se lo specchio fosse il mezzo attraverso il quale ci si può riconoscere e, se nella vita, lo specchio è rappresentato dagli altri, in questo caso si presenta coma una situazione ribaltata: dal figlio al padre.
Bisogna chiudere il cerchio per conoscersi davvero? Per rintracciare, per scoprire e per capire il proprio Io? Sembra essere questa la lezione che Siddharta ricava. Parlando con il ritrovato amico Govinda, nel frattempo diventato monaco, Siddharta spiega quanto segue:
"Quando qualcuno cerca - rispose Siddharta - allora accade facilmente che il suo occhio perda la capacità di vedere ogni altra cosa, fuori di quella che cerca, e che egli non riesca a trovar nulla, non possa assorbir nulla, in sé, perché pensa sempre unicamente a ciò che crca, perché ha uno scopo, perché è posseduto dal suo scopo. Cercare significa: esser libero, restare aperto, non aver scopo. Tu, venerabile, sei forse di fatto uno che cerca, poiché, perseguendo il tuo scopo, non vedi tante cose che ti stanno avanti agli occhi" (pag. 778).
Bella questa distinzione fra “cercare” e “trovare”, fra mirare a uno scopo ed essere pronti a raccogliere, sapersi porre in ascolto: “Siddharta ascolatava. (…) sentiva di avere appreso tutta l’arte dell’ascoltare” (ib. pag. 772). Siddharta ha compreso che per troppo tempo ha cercato, senza neppure sapere esattamente che cosa e infine ha trovato, ha trovato semplicemente ciò che aveva sotto gli occhi. Cercava una verità, una perfezione e ha trovato il suo Io imperfetto, quell’Io che non sa educare un figlio, che non sa riconoscere un’antica esperienza riproposta in forme nuove, che si affida all’amore di una prostituta e al digiuno dei Samana, quell’Io che non è né tutto bene, né tutto male, ma che occorre saper riconoscere come tale, quell’Io che può essere forte o debole, ma non “perfetto”.
"d'ogni verità anche il contrario è vero! (...) Quando il sublime Gotama nel suo insegnamento parlava del mondo, era costretto a dividerlo in samsara e nirvana, in illusione e verità, sofferenza e liberazione. Non si può far diversamente, non c'è altra via per hi vuol insegnare. Ma il mondo in sè, ciò che esiste intorno a noi e in noi, non è unilaterale. Mai un uomo, o un atto, è tutto samsara o tutto nirvana, mai un uomo è interamente santo o interamente peccatore. Bisogna conoscerlo in tutta la sua dimensione, il mondo. Nel suo bene e nel suo male, nella sua unità di fondo." (ibidem).

Siddharta non lo dice, lo aggiungiamo noi: se questo è vero per il mondo e gli uomini in genere, deve essere vero anche per Siddharta: conoscersi nella propria dimensione, nell’unità di bene e di male, questo vuol dire trovare il proprio Io. Non significa costruire un Io speciale su misura, a immagine di un Io ideale preso a prestito dalla religione, dai Samara, dalle prostitute, dai mercanti, dai saggi, da un barcaiolo, ma un Io che non è altro che il proprio, che si forma a contatto con le cose concrete, con il mondo e non a contatto con le dottrine o con gli insegnamenti impartiti e, allora, occorre prenderlo per quello che è. Per trovarlo non occorre “cercare”, occorre saper ascoltare.
Siddharta non ne parla, poiché il suo discorso si rivolge al mondo e forse questa è ancora la debolezza finale della sua posizione, non perfettamente compiuta. Occorre saper ascoltare se stessi, soprattutto. Questo ascolto non può essere “diretto”, è per forza mediato dal mondo stesso, dagli eventi, dalle circostanze, dalle esperienze, dagli altri soggetti, ma ogni esperienza rimanda a noi qualcosa e da noi ritorna al mondo qualcosa d’altro: è lì, in questo crocevia, che deve porsi un ascolto che voglia dialogare con l’Io, scoprirlo, scoprire se stessi.
Non è dunque il rapporto con le parole, intese come parole vuote, ideologiche, precostruite e per questo prive di significati (che sono delle convezioni artificiali), ma il rapporto con le “cose” a essere determinante per la scoperta della “propria strada”, cioè per la conoscenza di sè.
"Ma le parole non le posso amare. Ecco perché le dottrine non contano nulla per me: non sono né dure né molli, non han colore, non hanno spigoli, non hanno odori, non hanno sapore, non hanno null'altro che parole. Forse è questo che impedisce di trovare la pace: le troppe parole. (...) Penetrare il mondo, spigarlo, disprezzarlo, può essere l'opera dei grandi filosofi, Ma a me importa solo di poter amare il mondo, non disprezzarlo, non odiare il mondo e me; a me importa solo di poter considerare il mondo, e me e tutti gli esseri, con amore, ammirazione e rispetto" (pag. 781 - 782).
Il viaggio di Siddharta può dirsi concluso con l’esposizione di questo concetto. Il mondo va “amato”, non disprezzato o spiegato. Sulla base di questa posizione il viaggio si è concluso, ma non in quanto viaggio, che si ferma all’inizio della scoperta della verità e non trae ulteriori conclusioni. È vero che Siddharta accenna al fatto che l’amore per il mondo implica ed è alla base dell’amore per se stessi: “non odiare il mondo e me”, ma egli non è in grado di trarre la conclusione fondamentale del suo viaggio, che è evidentemente stato intrapreso, come abbiamo supposto in precedenza, per poter amare se stesso (che noi abbiamo tradotto in: cercare e trovare il proprio Io).

All’inizio del viaggio era dunque presente questo difetto di amore verso se stessso: “poter amare il mondo, non disprezzarlo, non odiare il mondo e me”, dice ora Siddharta. Egli disprezzava il mondo, nella sua religione il mondo è considerato samsara, illusione, mentre il vero è nel nirvana ed è il nirvana che occorre cercare, verso cui bisogna tendere. Ma quel mondo che Siddharta odiava e che poi ha riscoperto attraverso una serie di esperienze, non era altro che se stesso. Egli odiava se stesso e per questo è fuggito, per scappare da se stesso, dall’arte che odiava, dal suo Io che pure parlava a Siddharta con grande autorità e che pure lo ha salvato più volte dal cedimento di fronte a esperienze estreme.
Alla fine Siddharta si riconcilia con se stesso. Quando, esattamente, avviene questa riconciliazione? Solo quando si presenta il gioco dello specchio: egli, diventato padre, si trova a giocare la parte del suo stesso padre. Suo figlio gli fa da specchio. Ed egli, nello specchio, non trova la propria figura, ma quella di suo padre, il padre che ora è di fronte a suo figlio. Dunque Siddharta, alla fine, si riconcilia con il proprio padre, non con se stesso. Si riconcilia con un padre con il quale, per motivi che non sappiamo poiché nel libro non vengono trattati, era in aperto contrasto. Un contrasto che non appare come tale, come avevamo visto all’inizio, ma che contrappone due Io distinti.
Egli si riconcilia con il padre per il fatto di aver saputo che il suo Io è diverso da quello di suo padre. Siddharta non avrebbe mai potuto essere come il padre, non ne avrebbe mai seguito le orme e gli insegnamenti, non avrebbe ricalcato la sua vita, non avrebbe risposto alle sue aspettative. Questo, Siddharta lo sapeva molto prima di andarsene di casa, poiché il suo Io si era perfettamente costituito in modo del tutto indipendente da quello del padre, benché non lo sapesse riconoscere. Ma il suo Io esisteva ed era forte, così forte da sfidare il padre e la sua legge, che coincideva con la legge dei brahmini, cioè con la legge sociale, pagandone però un prezzo. Il prezzo di una sorta di scissione dell’Io: l’una indipendente, che chiamava Siddharta ad andarsene, a farsi la sua vita, a costituirsi come soggetto e l’altra che considerava questo atto come una offesa rivolta al padre.
Possedere un Io distinto? Per questo Siddharta non si amava, questa era l’origine del senso di colpa che lo spingeva ad andarsene, per compiere un viaggio che obbediva a due padroni: trovare il proprio Io e negarlo allo steso tempo.
Trovarlo, perché l’Io c’era, esisteva e negarlo perché il solo fatto di esistere, di essere diverso da quello di suo padre, spingeva Siddharta a non amarsi. Egli non amava il mondo e aveva abbracciato la via della religione perché non amava se stesso.
Solo alla fine, infatti, riconciliato con suo padre, avendo capito che l’andarsene del figlio non significa offendere il padre, ma rappresenta un atto necessario, solo alla fine Siddharta capisce di non aver affatto offeso il padre e dunque di non meritare alcuna punizione e quindi si riconcilia con lui e, a questo punto, può davvero abbandonare le concezioni filosofiche e religiose sul mondo, sul nirvana e sulla samsara per considerare il mondo come un solo grande oggetto da amare, un oggetto che comprende anche Siddharta stesso.

Dietro l’amore per il mondo c’era dunque il bisogno di Siddharta di essere amato. Ma, innanzitutto, amato da se stesso, poiché l’amore per stesso trasportava in realtà quello che lui credeva fosse l’amore (o il non amore), del padre verso di lui.
Tutto era nato nella testa di Siddharta e tutto si era risolto solo di fronte a un evento, il rapporto speculare con il figlio, la rivisitazione di un episodio, il transfert, diremmo oggi, la ripetizione del grande evento che rifletteva i rapporti fra padre e figlio.
Approfondisci con i miei eBook
Qui, in Gumroad trovi offerte speciali per i miei libri (che sono in tutti gli store, ma qui li trovi con sconti, gratis e in bundle). Ti segnalo il Bundle che comprende tre libri sul podcasting e puoi vedere anche racconti e romanzi per apprendere lo storytelling, libri di fotografia e di montaggio video, graphic novel, Intelligenza Artificiale, e diversi di questi sono gratuiti! E comunque, in tutti puoi applicare uno sconto del 25% inserendo il codice SCONTO25.
Vuoi avere notizie della qualità di Autore? Leggi questa pagina del mio sito: https://www.albertopian.it/pubblicazioni/